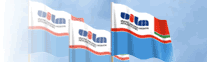Periodico nazionale di informazione della Uilm
ANNO IX - 6-7 giugno/luglio 2004
La
lezione di Melfi

Fiat
sta ad Agnelli come l’industria sta all’Italia.
Da tempo questa proporzione non sembra più stare in equilibrio.
La recente scomparsa di Gianni ed Umberto avrebbe fatto venire meno quel
cognome nel destino della casa torinese. Si tratta di un effetto che
incide solo nell’inconscio collettivo, dato che Andrea Agnelli, figlio
di Umberto, rimane nel Cda Fiat e insieme a lui i vari rami della
famiglia.
Di vero c’è che quando si evoca la Fiat, immediatamente a questa
ragione sociale s’associa la crisi del più importante gruppo
industriale italiano che opera da più di un secolo nel Paese.
In effetti è la parola crisi a squilibrare la proporzione che ha aperto
queste righe.
Negli ultimi decenni questo termine affiorava, talvolta in modo
esasperato. Gli spazi di mercato, la tecnologia applicata all’auto, la
capacità del gruppo dirigente, gli sforzi compiuti da più parti nel
Paese hanno consentito a questa azienda di superare ogni tipo di crisi e
di rimanere il più importante Gruppo europeo del settore fino alla metà
degli anni Ottanta.
Dalla primavera del 2001 questa parola ha rappresentato uno stato
ricorrente che provocava affanni all’azionista di riferimento, al
“management” e all’intera nazione.
Solo sei mesi prima dell’emergere della crisi più profonda che ha
colpito la Fiat, i sindacati
metalmeccanici presentarono all’azienda una piattaforma integrativa
che tra le varie rivendicazioni indicava anche come superare i problemi
della cosiddetta “doppia battuta” e dell’allineamento delle
maggiorazioni retributive per il turno di notte in diversi stabilimenti
del gruppo. Si tratta proprio dei due temi che hanno caratterizzato
principalmente la vertenza di Melfi, chiusa lo scorso maggio.
La vertenza sull’integrativo in Fiat del 2001, che doveva risolvere
proprio le questioni all’origine della recente vertenza di Melfi, non
andò a buon fine: trascorremmo dieci giorni nelle stanze del ministero
del Lavoro di via Fornovo, ma le mediazioni del ministro Cesare Salvi e
del suo fido sottosegretario Ornella Piloni non portarono a nulla.
Da quella volta non si è più ipotizzato un accordo integrativo per la
casa torinese, ma il Sindacato ha gestito eccedenze e mobilità. Da
allora il Sindacato ha discusso tre diversi piani industriali ed un
protocollo di mediazione firmato da azienda e governo, ma da nessuna
sigla sindacale (dicembre 2002).
Il Piano industriale voluto
da Umberto Agnelli e da Giuseppe Morchio è stato il migliore per capacità di guardare al futuro e per la scelta chiara e
netta di investire risorse proprie da parte della famiglia Agnelli nel
settore automobilistico.
Questo piano ha indicato nel secondo semestre del 2005 il pareggio dei
conti della Fiat.
E’ in questo scenario che Fim, Fiom e Uilm avevano cominciato ad
elaborare una piattaforma per il Gruppo che ponesse al centro
l’esigenza della vertenza integrativa per i lavoratori e che
coincidesse con i risultati positivi già prefigurati.
Dopo due contratti nazionali di lavoro (quello del 2001 e l’altro del
2003), firmati senza la Fiom, pareva che le tre organizzazioni sindacali
di categoria volessero incamminarsi congiuntamente lungo questo
percorso.
La sensazione rimase tale. Scoppiava dopo poco tempo la vicenda della
Sata di Melfi. Ciò accadeva la sera dello stesso giorno in cui i
sindacati metalmeccanici si erano riuniti insieme per discutere un
documento unitario.
Nello stabilimento potentino della Fiat, costruito più di un decennio
prima nel Meriodione d’Italia (anziché in Portogallo, o in Polonia
come voleva inizialmente l’azienda), divampava la protesta spontanea
dei lavoratori. La loro rabbia aveva motivazioni concrete: i turni di
lavoro relativi alla “doppia battuta” (questa turnistica era stata
modificata dapertutto, recentemente anche nello stabilimento di
Avellino, ma non a Melfi); l’equiparazione delle maggiorazioni
retributive a quelle degli altri stabilimenti; l’iniquità
dell’indiscriminato uso dei provvedimenti disciplinari.
Insomma, i lavoratori di Melfi avevano tutte le ragioni del mondo per
protestare e quei problemi dovevano essere affrontati prima, anche senza
aspettare la “vertenza di gruppo”. Questa è la legittima
autocritica che il Sindacato deve porsi: nonostante la crisi, ripeto,
quel paio di problemi dovevano esser presi di petto e risolti dalle
organizzazioni sindacali di categoria.
Bene protestare, ma come farlo?
La divergenza tra organizzazioni sindacali è nata proprio da qui, dalle
forme di lotta adottate.
Il “blocco” ha prodotto danni “tout court”: allo stabilimento
potentino, a quelli di tutto il Gruppo, alle aziende dell’indotto, ai
lavoratori.
Si poteva giungere allo stesso risultato finale senza pagare un prezzo
così alto per azienda e dipendenti. Quelle forme di lotta hanno inciso
pesantemente sul ciclo produttivo dell’intero gruppo.
Qualche forza politica ne ha approfittato anche nella campagna
elettorale per le elezioni europee accostando al “caso Melfi” lo
slogan “La lotta paga”. Sicuramente questa battuta ha prodotto
qualche voto per alcuni politicanti, ma nessun valore aggiunto alla
questione sindacale.
Gli intellettuali a contratto hanno pagato il loro obolo in termini
d’analisi: la lotta degli operai di Melfi paragonata per contenuti
alle proteste dei tranvieri di Milano, o a quelle del personale Alitalia.
Purtroppo, quello che univa le tre vicende, così diverse tra loro, era
esclusivamente la forma di lotta applicata: l’agitazione ad oltranza.
La soria del sindacalismo italiano ci ha insegnato che queste forme di
lotta fanno perdere tutto il sindacato. Nel 1980, proprio davanti ai
cancelli della Fiat di Mirafiori s’é consumato una frattura che il
Sindacato ha ricomposto dopo anni. Non poteva essere la primaverile
lotta di Melfi a determinare una rivincita ventiquattro anni dopo.
La stessa Fiom ha cercato di fermare “il carro in corsa”, tentando
così di recuperare la propria dignità storica: all’assemblea
patrocinata dai Cobas ha chiesto di “togliere il blocco”.
Persone e merci dovevano essere lasciate libere di circolare.
Nemmeno la Fiom è riuscita nell’intento, perché tra mille ingiurie
l’invito è stato accolto solo in parte. Allora tutto è stato chiaro:
“il carro non voleva fermarsi”, i Cobas ne avevano preso la guida,
le forme di lotta estreme erano dirette ed organizzate da loro.
I telegiornali di quel periodo hanno più volte trasmesso un’immagine
che rappresenta il logo di quei momenti convulsi: il segretario generale
della Fiom che in una piazza assolata rivolge i suoi inviti con un
megafono costellato dagli adesivi dei Cobas.
Qual è dunque la linea del Sindacato in merito alle forme di lotta da
applicare? Il recente congresso della Fiom, svoltosi a Livorno lo scorso
giugno non lo ha chiarito né a noi, né ai metalmeccanici della Cgil.
Per quanto ci riguarda manteniamo una certezza: siamo convinti che il
modello sindacale rimanga quello concertativo e partecipativo che
include in sé il conflitto sindacale.
Ma andare oltre, uscire dalle forme di lotta classiche, quelle a tutti
note, significa scegliere la sconfitta. Presumo che gli stessi organi di
informazione non vogliano questo.
Eppure, proprio loro si sono dilettati a contare le bandiere in piazza
di quanti avevano scelto lo sciopero ad oltranza, anziché rappresentare
le motivazioni, pur presenti, di quanti avevano sostenuto forme di lotta
alternative, più ragionevoli e costruttive.
Purtroppo, l’attenzione della maggioranza degli organi di informazione
si è soffermata quasi esclusivamente verso chi sosteneva “il
blocco”, anziché sottolineare, non dico la nostra posizione, ma
l’obiettività del contesto e del danno subito sia dai lavoratori che
dall’Azienda.
Il caso di Melfi rafforza la convinzione di chi scrive che ogni nuova
istituzione collettiva non può essere idealizzata.
Il Sindacato sta per incontrare il nuovo gruppo dirigente della Fiat. A
Luca Cordero di Montezemolo e Sergio Marchionne non potremo che chiedere
di continuare sulla strada tracciata dall’ultima presidenza Agnelli:
investire ancor di più sul prodotto, sulla ricerca, sul consolidamento
dei siti produttivi.
In questo scacchiere, Mirafiori va considerato come il nuovo perno dello
sviluppo e non “un problema sociale”.
Inoltre, la famiglia Agnelli dovrebbe consolidare ancor di più la
propria presenza nel capitale sociale del Gruppo. Ciò taciterebbe ogni
insinuazione sul ruolo di condizionamento delle banche rispetto al nuovo
“management” del Lingotto.
E magari, il Sindacato potrebbe avanzare quella vertenza integrativa che
i lavoratori della Fiat non conoscono dal lontano 1996.
Antonino Regazzi
|
|