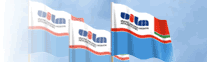Periodico nazionale di informazione della Uilm
ANNO IX - 6-7 giugno/luglio 2004
INTERVENTO
DI ALDO ANIASI
"Patto di Roma"
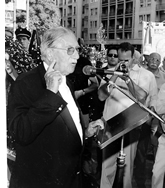
E' per me un privilegio partecipare a
questo incontro accanto ai dirigenti del movimento sindacale di oggi,
impegnati per reclamare una società più giusta, per difendere le
condizioni di vita dei lavoratori, per chiedere che il mondo viva in
pace ed anche per impedire che la Costituzione della Repubblica
Italiana, frutto della lotta di liberazione combattuta sessanta anni fa,
venga stravolta.
Una Costituzione fra le più civili del mondo che all'articolo primo
afferma che la Repubblica è fondata sul lavoro.
Una particolare soddisfazione è in tutti noi perché i dissensi fra le
tre grandi Confederazioni dei lavoratori sono alle nostre spalle e si è
ritrovata l'unità operativa senza la quale tutto sarebbe più fragile.
Grazie compagni e amici per questa opportunità che consente di
ricordare, di riflettere a chi ha vissuto la stagione dell'Unità
sindacale costruita mentre le truppe della Germania nazista, con la
complicità dei fascisti, calpestavano la nostra terra, compivano
stragi, eccidi, torturavano, assassinavano, deportavano chi si batteva
per la libertà.
La mia generazione non può dimenticare quei lavoratori, uomini e donne,
operai, impiegati, contadini, intellettuali che nelle fabbriche, negli
uffici sostenevano la Resistenza armata affrontando le feroci criminali
repressioni e che a migliaia pagarono con la deportazione e con la vita
quella loro resistenza disarmata.
Noi oggi ricordiamo con animo riconoscente un avvenimento di eccezionale
importanza: la decisione di unire in una sola organizzazione i
lavoratori del Sud e del Nord il che influì positivamente sulla guerra
allora in corso e creò le condizioni per la ricostruzione pacifica in
un dopoguerra che doveva traghettarci verso la democrazia.
Oggi appare un miracolo quello che sessanta anni fa portò il mondo del
lavoro a stringere un patto unitario dopo due decenni che lo avevano
visto diviso in Italia, in Francia negli anni della lotta antifascista.
Voi sapete, quanto me, quanto sulla caduta del fascismo abbiano influito
gli scioperi del marzo del '43: indebolirono le già fragili strutture
del regime e fecero pressione sulla tenuta della monarchia, che portava
la responsabilità di aver avallato e sostenuto il fascismo, i suoi
crimini, la guerra.
Quegli scioperi furono non solo organizzati e attuati per rivendicare
migliori condizioni economiche ma anche contro l'oppressione fascista,
contro la guerra, la fame, le privazioni, le basse paghe; la situazione
politica consentì agli antifascisti militanti di trovare sostegno in un
indistinto complesso di risentimenti della popolazione contro le
disfatte, le disgrazie causate dal fascismo.
Fra i militanti antifascisti e la popolazione si stabilì una
solidarietà che si rafforzò nei mesi successivi.
Con la caduta del fascismo, il 25 luglio del '43 al ritorno anche se
brevissimo dei Partiti Politici, si creò la possibilità di manifestare
pubblicamente rabbia, risentimenti a lungo covati e repressi.
In quei giorni si gridava "Viva Matteotti", il martire
assassinato 19 anni prima, si venivano a conoscere i nomi dei dirigenti
sindacali antifascisti: Buozzi, Roveda e Grandi e altri divennero la
bandiera dei lavoratori.
Gli antifascisti usciti dal carcere, dal confino, rientrati dalla
Francia assunsero la direzione del movimento, la maggioranza dei
lavoratori in quelle giornate si ritrovò unita in un comune sentire: la
presa di coscienza delle ingiustizie, dei torti subiti, e la speranza in
parole nuove e a lungo ignorate: libertà, giustizia, pace, il che
determinò una indistinta generica solidarietà: la solidarietà di
classe.
Oggi mi sembra di sentire quello slogan di allora: "uniti si
vince" che fu inconsciamente la molla che impresse forza al
movimento unitario.
I dirigenti con lunga esperienza sindacale quali Bruno Buozzi, Giuseppe
Di Vittorio, Achille Grandi, Oreste Lizzadri ebbero il merito,
l'intelligenza di interpretare quei sentimenti, quelle aspirazioni e di
operare perché essi si traducessero in fatti.
La Resistenza nata dopo l'8 settembre, dopo il proclama del Generale
Kesserling, che dichiarò il territorio italiano sottoposto alle leggi e
ai tribunali tedeschi, fu un potente detonatore per innescare l'unità
del mondo del lavoro.
Da quel momento la parola d'ordine del C.L.N. fu : "unità di
popolo, unità dei partiti".
La Resistenza fu quindi plurale ma unitaria. Consentitemi ricordi
personali: gli operai dell'Isotta Fraschini di Milano, che ci
rifornivano di armi, quelli della Rumianca, dell'Ilva, della Montedison,
che ci sostenevano nella Valdossola con concrete iniziative, non ci
chiedevano a quale partito appartenessimo.
Era una unità fra diversi, unità dialettica, unità faticosamente
raggiunta, imposta dalla durezza della lotta.
Gli scioperi per rivendicazioni economiche e contro gli invasori si
susseguivano. Nel dicembre '43 a Sesto San Giovanni, allora grande
centro industriale, lo sciopero fu totale; nei primi del gennaio '44 si
estesero alla Franco Tosi di Legnano, alla Comerio di Busto Arsizio ed
in altre località.
Hitler e il generale Wolf preoccupati per l'allargarsi della rivolta
inviarono in Lombardia il generale Zimmerman con pieni poteri per
reprimere ogni sedizione.
Il 28 febbraio 1944 l'Avanti! clandestino (edizione milanese) aveva
riportato l'o.d.g. del C.L.N. - A.I. d'appoggio allo sciopero proclamato
dal Comitato segreto d'iniziativa, sostenendo che si trattava di uno
sciopero generale insurrezionale.
Per una settimana, dal 1° marzo, alcune centinaia di migliaia di
lavoratori avevano bloccato tutte le produzioni belliche.
La reazione, la repressione delle SS fu brutale.
Queste vicende consolidarono i vincoli unitari del mondo del lavoro e
furono il terreno che consentì la stipulazione di quello storico Patto
di Roma firmato in una giornata drammatica, il 3 giugno del '44.
Le forze armate germaniche in fuga da Roma, quel giorno, trascinarono
con se 14 patrioti e li assassinarono alla "Storta" sulla via
Salaria.
Fra essi, Bruno Buozzi che era stato il lungimirante ideatore di quel
disegno unitario e il paziente costruttore dell'accordo. Ne si
dimentichi che fra le carte che gli trovarono al momento dell'arresto
c'erano anche le bozze dei primi progetti per la realizzazione della
unità sindacale.
Buozzi, Grandi, Roveda e Di Vittorio erano stati i sostenitori
dell'autonomia delle organizzazioni sindacali dalla interferenza dei
partiti.
La perdita di Buozzi lasciò un vuoto incolmabile.
Buozzi era stato un dirigente sindacale che aveva fatto la sua
esperienza nei primi anni del fascismo, quale Segretario Generale della
F.I.O.M. che aveva firmato il contratto nazionale di lavoro di 8 ore.
Nel 1925, da deputato socialista per alcune legislature, espatriato per
sfuggire alle persecuzioni, aveva continuato il suo impegno fra miseria,
stenti, carcere, campo di concentramento; riprese il suo posto di
combattimento in Italia alla caduta del fascismo.
Quel Patto che oggi noi onoriamo fu recepito con grande consenso
nell'Italia del centro e del Nord nella quale operava attivamente la
Resistenza.
Nell'estate del '44 le "Repubbliche Partigiane", nelle zone
liberate, accolsero ed attuarono le indicazioni del Patto di Roma.
Ricordo che il 16 settembre il "Governo Provvisorio dell'Ossola"
nel
suo primo atto dava indicazioni per costituire la Camera del lavoro, per
l'organizzazione unitaria delle forze lavoratrici e per la costituzione
e l'adesione alla C.G.I.L., suggerendo inoltre di affrontare con urgenza
gli aumenti salariali per "rimediare " - si affermava - ai
più impellenti bisogni delle masse lavoratrici.
Era la presa d'atto di quanto aveva stabilito la Direzione Provvisoria
della C.G.I.L. (Confederazione Generale Italiana del Lavoro): promuovere
l'organizzazione e l'inquadramento del movimento sindacale in tutte le
regioni liberate unitamente alla rigorosa difesa degli interessi dei
lavoratori e sostenere con tutte le proprie forze la guerra di
liberazione totale del Paese.
Quel patto firmato da Giuseppe Di Vittorio, Emilio Canevari, Achille
Grandi si collegava, si intrecciava indissolubilmente con la Resistenza.
Non era stato facile, come sapete, quell'accordo.
Le questioni sulle quali c'era dissenso non erano di poco conto: la
scelta del sindacato unitario ma non unico, l'assoluta autonomia dallo
Stato, dai partiti e dal padronato, la validità giuridica dei contratti
di lavoro ed altro ancora.
Non erano state di poco conto le questioni affrontate e discusse.
Emilio Canevari, Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi operarono
unitamente ai dirigenti dei partiti politici per superare contrasti e
dissensi, operarono per una mediazione che interpretava e faceva suoi
sentimenti e volontà della base dei lavoratori.
Importante fu l'apporto di Nenni, Amendola, Gronchi.
La scelta dell'indipendenza dei partiti, ma non della indifferenza, fu
allora la formula che consentì di avere il consenso dei dirigenti dei
partiti politici che non avevano partecipato alla stesura del Patto.
Nacquero da quel Patto le Camere del Lavoro, in netta rottura con le
concezioni corporative di categoria.
Quel Patto di Roma ebbe grande importanza nei 10 mesi successivi, nei
quali i lavoratori dell'Italia occupata si sentirono uniti strettamente
nel combattere per migliori condizioni di vita ma anche per la difesa
del patrimonio industriale dai tentativi di sabotaggio e di rapina dei
tedeschi in fuga.
Il primo congresso della C.G.I.L. tenutosi a Napoli dal 28 gennaio al
1° febbraio del '45 quando ancora la guerra era in corso manifestò
grande entusiasmo per una unità che facilitava l'affermarsi di una
democrazia fondata sulla tolleranza delle diversità nel segno della
solidarietà e del rispetto delle minoranze.
Fu quel Patto, quell'unità che favorì un dopoguerra meno conflittuale,
che consentì di unire i lavoratori del Nord e del Sud che avevano
vissuto due esperienze così diverse; quel Patto fu uno strumento per
ridurre la diffusa aggressività del dopoguerra che rischiava di
esplodere e di rendere più difficile la convivenza e la ricostruzione
industriale, economica e civile del Paese.
L'Avanti! del 1° maggio '45 salutava la C.G.I.L. che - così affermava
- costituisce uno strumento a garanzia per il risanamento morale e
materiale del Paese.
Una unità del mondo del lavoro che evitò situazioni drammatiche dopo
l'uscita delle sinistre dal governo, che sopravvisse, anche se di poco,
alle laceranti elezioni del 1948.
L'incontro di oggi non è stato concepito dagli organizzatori solo come
la celebrazione di un "grande avvenimento" di 60 anni fa, ma
come l'occasione per una riflessione valida per l'oggi.
Quattro anni di unità, cinquantasei anni di divisioni delle
organizzazioni.
Ma quel patto ha lasciato un ombra lunga sulle vicende vissute dal
nostro Paese in questi decenni.
Nonostante la guerra fredda, le laceranti divisioni ideologiche, il
mondo del lavoro è riuscito nei momenti drammatici a ritrovare rapporti
e comportamenti unitari e solidali.
Lo stragismo dei fascisti, il terrorismo delle brigate rosse sono stati
vinti grazie alla memoria storica di quella unità e solidarietà, con
metodi democratici, senza leggi speciali.
Dopo ogni attacco, dopo ogni minaccia, le piazze si sono riempite di
cittadini, di lavoratori sotto questo segno, senza distinzioni di
appartenenza sindacale.
Unitariamente furono respinti i tentativi di chi voleva portare il Paese
verso soluzioni autoritarie.
Una riflessione si impone sul ruolo del movimento delle organizzazioni
dei lavoratori di oggi e del futuro.
Per la società di domani caratterizzata da innovazioni tecnologiche che
imporranno di cambiare lavoro più di una volta nella vita e forme di
lavoro più flessibili, sarà indispensabile una istruzione e formazione
professionale permanente per rendere meno precaria l'occupazione e per
migliorare la qualità della vita.
Già oggi sono migliaia le imprese con meno di 10 dipendenti, sono
centinaia di migliaia i lavoratori non sindacalizzati che non sono
tutelati e quindi privi di rappresentanza.
Una moltitudine di lavoratori fruisce di contratti atipici, il popolo
della partita IVA e di altre forme contrattuali è in forte crescita.
Oggi come 60 anni fa, l'esigenza della unità delle organizzazioni dei
lavoratori e degli imprenditori impone organizzazioni unitarie e
sottratte a legami con i Partiti il cui ruolo, per sua natura, è
diverso.
Una riflessione che si amplia in considerazione di un sistema elettorale
maggioritario che influisce in modo assai diverso che nel passato nei
rapporti governo - sindacati - imprese.
Non sono un esperto di problemi sindacali e non mi permetto di
intervenire su problematiche che non conosco a sufficienza.
Ma non posso ignorare gli eccezionali compiti che deve affrontare oggi
il movimento sindacale: la difesa dell'ambiente, della salute,
dell'occupazione, delle condizioni di vita delle donne, degli anziani,
della integrazione dei lavoratori immigrati e via dicendo. Consentitemi
però di coltivare un sogno, un'utopia, che si realizzi l'unità dei
lavoratori in una sola grande confederazione: quella unità fra diversi
che è stata vincente 60 anni fa e nei primi anni del dopoguerra,
darebbe un grande contributo al superamento della crisi e al declino
economico e sociale in atto, favorirebbe il dialogo del mondo del lavoro
con quelle forze della Società e delle imprese che sono disponibili
alla concertazione.
I sogni, le utopie sono sempre stati la molla che hanno generato le
grandi realizzazioni della storia.
Aldo
Aniasi
|
|